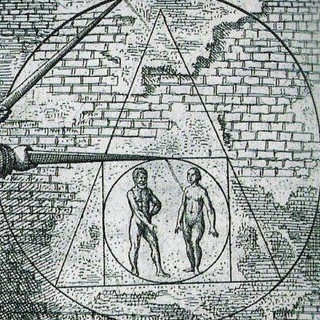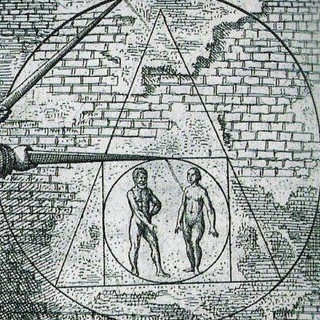2023-03-13 00:03:02
#alchimia
Roberto Zamperini,
Ritorno a Notre-Dame: come uccidere l’anima di una città (2).
Continua dall'articolo precedente.
2) L’Alchimista e il libro di pietra dell’Alchimia. «Se, spinti dalla curiosità, o per dare uno scopo piacevole alla passeggiata senza meta d’un giorno d’estate, salite la scala a chiocciola che porta alle parti alte dell’edificio, percorrete lentamente il paesaggio, scavato come un canale per lo smaltimento delle acque, sulla sommità della seconda galleria. Giunti vicino all’asse mediano del grande edificio, all’altezza dell’angolo rientrante della torre settentrionale, noterete, in mezzo ad un corteo di chimere, il sorprendente rilievo d’un grande vecchio di pietra. E’ lui, è l’Alchimista di notre Dame. Col capo coperto dal cappello Frigio, attributo dell’Adeptato, posato negligentemente sulla lunga capigliatura dai grandi riccioli, il saggio, avvolto nel leggero camice di laboratorio, s’appoggia con una mano alla balaustra, mentre, con l’altra, accarezza la propria barba, abbondante e serica. Egli non medita, osserva. L’occhio è fisso; lo sguardo possiede una straordinaria acutezza. Tutto, nell’atteggiamento del Filosofo, rivela una estrema emozione. La curvatura delle spalle, lo spostamento in avanti della testa e del busto tradiscono, infatti, una grande sorpresa. In verità, questa mano pietrificata sembra animarsi. E’ forse un’illusione? Sembra di vederla tremare… Che splendida figura questa del vecchio Maestro che scruta, interroga, curioso ed attento, l’evoluzione della vita minerale, e poi, infine, abbagliato, contempla il prodigio che solo la propria fede gli faceva intravedere! E come sembrano misere le moderne statue dei nostri scienziati – che siano colate in bronzo o scolpite nel marmo – in confronto a questa raffigurazione venerabile, dal realismo così potente nella sua semplicità!»
Così scriveva il
Fulcanelli nel suo “Il Mistero delle Cattedrali”. Ma lo stesso andava oltre, convintissimo che l’etimologia di “Arte Gotica” andasse ricercata in
argot, ovvero in quella sorta di «linguaggio particolare di tutti quegli individui che sono interessati a scambiarsi le proprie opinioni senza essere capiti dagli altri» che deriverebbe addirittura dagli «argonauti, i quali andavano sulla nave Argo, parlavano la lingua
argotica, – la nostra lingua verde – navigando verso le fortunate rive della Colchide per conquistare il famoso Vello d’Oro». Credo che mai Fulcanelli sarebbe stato d’accordo con me e con le mie tesi e mai avrebbe ammesso che la sapienza di coloro che costruirono le sue amate cattedrali affondasse principalmente – anche se non esclusivamente – in quella Roma che doveva proprio detestare, se alla stessa non dedica mai neppure un rigo del suo celebre libro! (A proposito: mi dicono che le sue opere siano ormai introvabili in Francia, se non nelle librerie d’usato. Spero non sia vero, perché sarebbe cosa gravissima).
In ogni caso e quale che sia la nostra opinione sulle sue idee o la sua sulle nostre, quella di Fulcanelli è una tesi interessante e degna di essere approfondita. Allora chiediamoci: chi erano gli
Argonauti e cosa hanno fatto? Come sarebbero finiti in una cattedrale gotica o addirittura in un intero periodo storico dell’architettura francese? Secondo la Mitologia Greca, gli Argonauti erano una cinquantina di eroi che, guidati da Giasone, a bordo della nave Argo, se ne andarono per mare alla volta dell’ostile
Colchide per conquistare il
vello d’oro. La storia è lunga e complessa, ma ci basterà mettere in luce alcuni particolari.
1 - Intanto ecco che nella storia vediamo subito comparire
Eracle (Ercole) che viene proposto come comandante, ma, al suo rifiuto, è il giovane Giasone che se ne occupa e proprio su indicazione dello stesso Ercole.
2 - E c’entra anche
Apollo al quale i 50 sacrificano, prima ancora di alzare l’ancora, per propiziarsi il viaggio?
42 views21:03